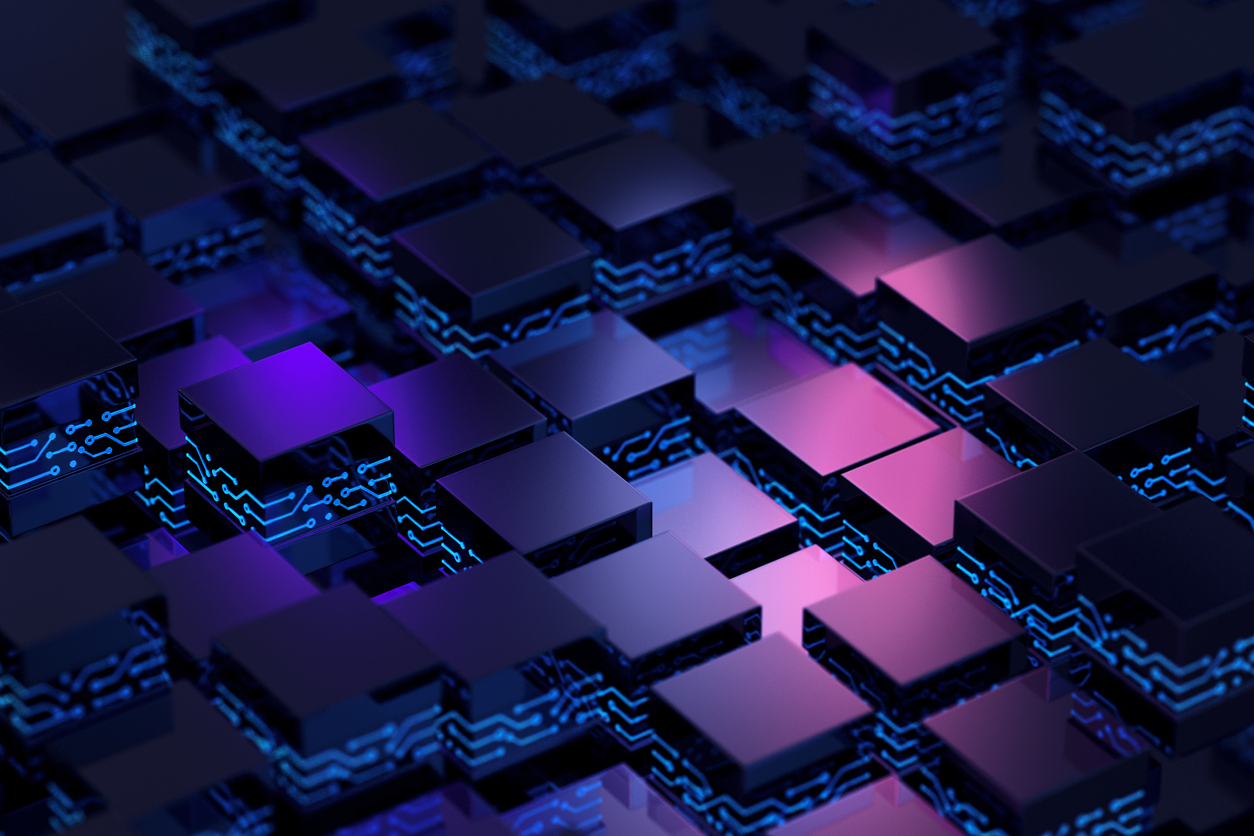- Tempo di lettura 8 min.
L'intelligenza artificiale (Artificial intelligence - AI) e gli algoritmi sono sempre più indiscussi protagonisti delle nostre vite e delle nostre scelte, molto spesso in maniera inconsapevole. In particolare, gli algoritmi sono strumenti invisibili che regolano le attività sui social network e sui motori di ricerca, le mappe di navigazione stradale, il traffico ai semafori, gli autovelox, la giustizia predittiva, l'assistenza sanitaria e gran parte del settore economico, dall'andamento dei mercati al calcolo dei prezzi o, ancora, ai sistemi di efficientamento delle decisioni in ambito commerciale e finanziario.
Il potere degli algoritmi sta nella loro capacità di aiutare l'uomo a risolvere problemi, perché permettono di arrivare a soluzioni più oggettive e più efficienti in tempi minori, motivo per cui, secondo il parere di Alessandro Curioni (vicepresidente di IBM Europe), non utilizzarli sarebbe un grave errore. Un utilizzo necessario, quindi, pur nella consapevolezza che gli algoritmi possono essere deviati, introducendo nel data set parametri modificati (ovvero coppie di input-output), con alterazioni anche impercettibili, ma che portano l'algoritmo a sviluppare distorsioni cognitive causate dal pregiudizio (c.d. bias), che, da un lato, sono difficili da indentificare e, dall'altro, possono produrre conseguenze estrem...
 Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Intelligenza artificiale nel mondo HR: quali impatti sui diritti dei lavoratori?
Una questione al centro dell'attuale dibattito è l'impiego di software dotati di Intelligenza artificiale, che tramite la raccolta di dati dei candidati, si propongono di sostituire l..
di Chiara Ciccia Romito - PhD - Avvocato - Consulente Commissione Parlamentare Inchiesta Condizioni di Lavoro
Iscriviti alla Newsletter
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Trovi interessante questo video?
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.